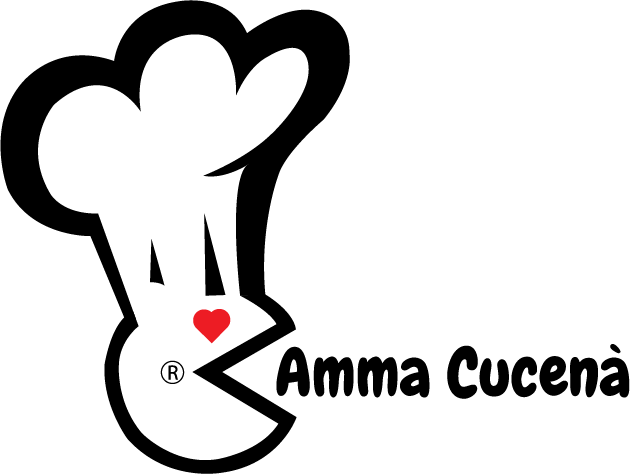“Não entres tão depressa nessa noite escura”
A.L.A.
Questa qui sotto è una foto del 2014, di ottobre per la precisione, scattata sul punto più alto del Parque Nacional Podocarpus, nella provincia di Loja, nella parte di foresta Amazzonica che sta in Ecuador.

È l’alba e sotto, nell’album digitale dove la tengo conservata, c’è una didascalia a ricordarmi che erano le 5 e 50. Per arrivare a quell’ora, avevamo iniziato la nostra risalita parallela a quella del sole alle 3 di notte. La prima tappa, un sentiero costeggiato su ambo i lati da una miriade di lucciole a perdita d’occhio. Ci facevamo strada nell’oscurità ritrovata dopo la visione e la meraviglia degli insettini luminosi con una lampada frontale accesa proprio sopra i nostri sguardi ancora assonnati e una copertura quasi totale sul corpo a proteggerci dalle zanzare. Il caldo della stagione e della zona sembrava ancora più appiccicoso. La frontale ti illuminava a stento il cammino, ti faceva notare qualche ragno gigante da schivare tempestivamente sui rami a cui ti volevi appoggiare e ti obbligava a focalizzarti solo ed esclusivamente su quello che avevi davanti. Tutto intorno, il buio totale e suoni improvvisi, emessi soprattutto da uccelli e animali di vario tipo. Il ritmo della risalita era sostenuto. Quasi non si parlava.
In Ecuador c’ero andata per 3 settimane con persone che non conoscevo, tutte francesi e una spagnola (ne ho già parlato qui). Capitò che fossimo tutte donne, tranne la guida: un argentino stanco dell’Argentina e della Francia, dove aveva vissuto qualche anno. Tra noi viaggiatrici si condividevano spazi, umori, soprattutto entusiasmi e si creavano alleanze. C’era anche chi tracciava una linea per fortuna labile e sottile tra le buone e le cattive del film (traduco un’espressione spagnola che mi piace tanto*) e chi provava a capire con chi avrebbe potuto dividere la stanza della prossima tappa senza creare troppi intoppi reciproci: un viaggio così lungo e così lontano meritava di essere vissuto nel più liscio dei modi possibili. Almeno una, che io sappia e senza essermene interessata più di tanto, in modo conclamato, si infatuò dell’argentino.
Eravamo arrivate tutte da posti diversi della Francia, nel cuore di una notte a Guayaquil. Quelle prime ore di sonno latinoamericano condiviso e intermittente le avevamo passate in gruppetti in stanze coi letti a castello, facendo a turno le presentazioni di rito. All’inizio eravamo in 8 e durante l’ultima settimana si sarebbero aggiunte al gruppo una signora belga e le sue tre figlie adolescenti. Per le tappe seguenti al nostro arrivo, io divisi la stanza sempre con la malinconica medica palliativista di Lione. Non ci eravamo veramente scelte, ma eravamo forse quelle all’inizio più silenziose e sobrie e anche più grandi (lei un po’ più di me): più grande di noi ci stava solo M.P. di Annecy, instancabile camminatrice ultrasessantenne e dispensatrice di entusiasmo sincero per ogni minimo dettaglio di persone, cibo e paesaggi. Nonostante la sua malinconia, che la rendeva apparentemente riservata, a cui con lo scorrere dei giorni avrei potuto iniziare a dare nomi e contesti, la medica palliativista mi incalzava spesso con domande per me troppo personali per il troppo poco tempo condiviso. Per alcune finii per cedere, mantenendo comunque diplomaticamente zone sacre. A permettermi di fare una pausa per farmi imparare a gestire gli imbarazzi di altre domande per il resto del viaggio fu l’arrivo nella foresta Amazzonica una sera e l’invito, da parte della guida, a recarci a vedere l’alba (quella della foto), a piedi, sul punto più alto del Parque Podocarpus quella notte stessa. Per arrivare in tempo, la partenza era prevista due-tre ore prima del sorgere del sole. Non tutte erano disposte alla levataccia e alla salitaccia: la medica palliativista era in modalità chimoffafà**, e in quella notte di poche ore di sonno, per coincidenza di orario di risveglio, divisi il bungalow completamente circondato di zanzariere per l’assenza di vetri alle finestre con M.P. di Annecy. Lei e altre 2 del gruppo erano più che motivate a intraprendere la scalata delle 3 di notte assieme all’argentino. Nessuna domanda scomoda da parte sua, ma solo commenti di meraviglia condivisa per ogni voce di uccello sconosciuto che rompeva il silenzio dell’animatissima notte in piena fauna amazzonica. Ogni tanto ci tranquillizzavamo a vicenda per rumori di presenze di chissà quali animali intorno al bungalow.

Dopo l’alba più bella, meritata e rafforzatamente irripetibile che io abbia mai visto, riprendemmo il viaggio, tornai a condividere una stanza catapecchia con la medica palliativista e dopo quell’esperienza quasi mistica delle prime ore del mattino riuscii ad accogliere ogni tipo di conversazione e anche a non badare troppo alla fatiscenza dell’alloggio.
Con lei e con M.P. ci fu poi una reazione condivisa a una scena che si rivelò scomoda per tutte le altre, cosa che rafforzò il nostro trittico di sodalizio quasi per il resto del viaggio. Il pomeriggio prima di arrivare alla destinazione che ci avrebbe viste ferme per 2 settimane, ci ritrovammo in uno spazio verde e oro per il secco della vegetazione, costellato da sporadiche forestelle nella zona di Limón, nei pressi di Zamora Chinchipe. Dopo aver attraversato un lunghissimo ponte traballante, la guida ci consigliò una sosta in un posto all’ombra, vicino a un corso d’acqua, dopo ore di cammino sotto il sole per consumare in un pic-nic il pasto acquistato la mattina in un mercato popolare.

A un certo punto, non molto lontano dalla nostra zona, arrivarono 3-4 famiglie con un grosso maiale trascinato per una corda che gli avevano legato stretta al collo. Gli uomini lo immobilizzarono vicino a un albero e iniziarono a estrarre i coltellacci per ammazzarlo. Notate le intenzioni dei nuovi arrivati, tutto il nostro gruppo, tranne la guida, M.P., la medica palliativista e io, fece pressione per andare via, per non sentire il grido assordante dell’imminente agonia del maiale. Eravamo tutte coscienti del fatto che l’animale stesse per fare una brutta fine e che lo avremmo sentito comunque, anche se ci fossimo allontanate di parecchio, per non parlare del fatto che andando via da lì, saremmo capitate di nuovo sotto il sole sempre più insopportabile. Era come se noi tre – le “grandi” – e la guida volessimo provare a guardare in faccia quel dolore così insopportabile e per cui non potevamo fare niente… Sapevamo inoltre che, pur spostandoci altrove, le grida del maiale sgozzato avrebbero finito comunque per perseguitarci. E così fu… Per assecondare le “piccole”, recuperammo stoviglie e bagattelle e cambiammo posto, ma quando la lama del primo coltello affondò nella gola dell’animale la sua voce straziò tutta la natura circostante prima di lasciare posto a un silenzio innaturale. La guida aveva visto e rivisto quella scena mille volte e partecipato a mattanze di maiali e altri animali che in Ecuador o Argentina si è soliti mangiare. Per resistere, forse io facevo invece leva su racconti e voci di maiali ammazzati in lontananza a cui avevo già assistito. La medica palliativista e M.P. non avevano il mio stesso vissuto rurale, ma forse, a renderle vesdine*** quanto me, era il fatto che l’una vezzeggiava la morte nel suo quotidiano di malati terminali, mentre l’altra si portava addosso, sotto la scorza ormai luminosa di tanti entusiasmi e sorrisi ritrovati, – lo avremmo scoperto poi – una tragica vedovanza. All’epoca io, invece, avevo intravisto la morte di persone care solo da lontano, ma intorno a me, da piccola, tra mamma e le nonne, si erano sempre ammazzati polli, conigli e quelle scene di mattanza non mi erano mai state risparmiate, anzi… Forse nelle mie antenate c’era una speranza di passaggio di testimone che poi non è mai avvenuto e non credo avverrà. Ci ritrovammo a consolare le piccole e a razionalizzare anche per loro quell’atrocità appena consumata sotto le orecchie di tutti. Mi sentii come una mia cugina più grande, che da bambine, a ogni mattanza del maiale, dell’amma accir’u puorco nell’orto di suo nonno in zona Starza, a Procida, a cui erano stati invitati anche i miei, mi portava lontano dal porcile provando a distrarmi con storie e descrizioni di varie situazioni buffe. Ricordo che io volevo sempre cercare le case dei puffi tra le piante di carciofi: mio zio, papà di quella cugina e fratello del mio, raccontava storie incredibili sulla presenza degli esserini blu nell’orto della Starza e si divertiva molto quando dopo minuti di incredulità rivendicata al ritmo di altisonanti “non è vero!” con voce di bambina stizzita, parevo cedere e lasciavo scorgere sorridenti lampi di possibilismo: i puffi esistono, stanno in mezzo all’orto… era una delle leggende divertenti dell’infanzia, insieme a quella della Befana.
Quanno s’accereva u puorco, di solito a inizio febbraio o in ogni caso prima di Carnevale, gli uomini della famiglia che non erano imbarcati si occupavano della mattanza, affidandosi in genere anche alla guida di un macellatore più esperto. Le donne, invece, erano addette al lavaggio delle budella – che poi sarebbero servite per salamelle varie e salsiccia – e al taglio e alla distribuzione della carne tra i vari partecipanti al rito sacrificale.
Anche in quel posto sperduto in fondo all’Ecuador le donne parevano avere lo stesso compito, assonanza che mi fece provare per loro una forte simpatia, quasi si fosse trattato di persone di famiglia.

Per il resto di quel viaggio, poi, nella spaziosissima casa sulle Ande, a San Juan, dove ci fermammo 2 settimane, finalmente le 3 “grandi”, ovvero io, M.P di Annecy e la medica palliativista di Lione, avevamo stanze singole che ci permettevano di fare vere pause ristoratrici dagli accadimenti del giorno. Ci ritrovavamo tutte e tre puntualmente ogni mattina, dalle 6, in cucina, per chiacchierare del più e del meno e preparare la colazione per il resto della combriccola.
Quando ripenso a quei giorni, ricordo spesso anche di come venimmo a sapere della scomparsa del marito di M.P: ce lo raccontò a tutte, dopo un rituale liberatorio operato da uno sciamano locale con un porcellino d’India (una specie di “soba del cuy****”) a cui lei e un’altra del gruppo si erano offerte di partecipare. Da quel momento, sul liscio dei fili di complicità che tutte e tre le grandi tessevamo ogni mattina, spuntarono dei nodi… Chissà se il tempo sarebbe poi riuscito a scioglierli… Io ero apparentemente ancora impigliata in una neutralità sciapa e alla lunga logorante, ma a differenza della medica palliativista, non vedevo il gesto di M.P come qualcosa di teatrale per attirare l’attenzione: non sta di certo a me né forse a nessun’altro azzardare personalissime gerarchie del dolore, ma la medica palliativista pareva essersi talmente assuefatta alla morte di mestiere, da non riuscire ancora a digerire che la morte di un matrimonio – la sua malinconia – finisce per rivelarsi più naturale di quella di un marito, di una moglie o affini. Crollarono certezze, si sfibrarono confidenze: in quel dove e in quel tempo non resse il confronto tra dolori.
Mi colpì moltissimo il fatto che M.P. avesse deciso di condividere quella pena distribuendola tra ogni partecipante della spedizione e quasi alla fine del viaggio, senza caricare nessuna in particolare di esclusività impreviste e premature.
Sono passati tanti anni e io di Lille, M.P. di Annecy e la medica palliativista di Lione ci siamo perse di vista. Con lo scorrere di tutto questo tempo ho iniziato a essere triste anche per quel contadino procidano o ecuadoreño o chissà di dove che ha allevato il maiale per tanti mesi per poi ammazzarlo: chissà se l’appello ad amici e famiglia per la mattanza, oltre a un aiuto concreto, apporta anche sollievo per un dolore condiviso. Forse sto proiettando, non so. So solo che col maiale ammazzato, con le sue parti meno nobili, si fa la liatina e che l’ultima liatina, prima di quella preparata con mia madre per l’arrivo di mio fratello il giorno della Befana di quest’anno, la cucinò papà per la festa procidana dei miei quarant’anni. Per quell’occasione cucinammo in squadra: papà la liatina e le fave, mamma le pizze di scarola, io i crocchè e gli arancini che mio fratello mi aiutò pazientemente a friggere.

Il giorno di quel compleanno – la festa si sarebbe svolta circa una settimana dopo – molto presto la mattina, io e i miei, con altre persone di famiglia, ci recammo al cimitero per un trigesimo. Erano gli anni in cui anch’io stavo cominciando a interagire con la morte di persone care più da vicino… Ed era solo l’inizio.
Alla fine di quella stessa mattinata, papà, mamma e io ci imbarcammo sul Don Peppino per andare a Pozzuoli a comprare la carne per la liatina della festa nella macelleria preferita di mio padre, Di Francia, negozio a conduzione familiare. In quel posto, dove si recava sempre con grande entusiasmo, papà era sempre accolto calorosamente.
In quel negozio, due estati fa che siamo tornate a Pozzuoli e tu non c’eri più, mamma non è riuscita a rimetterci piede. Per la liatina della scorsa Befana abbiamo delegato una spedizione puteolana. Civilmente o civicamente, più che geograficamente, di Francia intanto, adesso, dopo un iter burocratico di cui avevo dimenticato l’inizio e che tu avevi visto nascere, sono diventata io, oltre che di Procida. È successo in questi primi di febbraio di notti insonni di Sanremo e tempeste di vento peggio di quelle degli inverni di Solchiaro. “Diventa anche francese!” mi consigliavi, “non smettere mai di darti tante possibilità, è sempre un di più e non un di meno”.
E quel di più incoraggiato, adesso c’è: è anche un decreto a forma di lettera dai toni aziendali firmato da Macron, ma è fatto di ricordi di M.P, di medica palliativista, di nostalgie di Diam’s e Ma France à moi che ci faceva ascoltare la prof di francese dei corsi serali per adulti della mairie del mio quartiere parigino. È quella Génération nan nan dei primi anni duemila, dei secondi e forse anche dei terzi. È l’Espérance de vie scoperta subito dopo l’Hexagon di Fary insieme a tre amiche della capoeira – “c’est qui qui chante ça?” – che ormai non faccio più. Soprattutto, è forse l’inizio della fine di una sensazione di ingiustificate e ataviche asimmetrie, almeno con questo paese.
Febbraio è arrivato anche quest’anno e neanche quest’anno mi piace il Carnevale e neanche quest’anno sono riuscita ad andare in Brasile, quel Brasile che mi raccontavi sempre tu e dove io vorrei sempre andare per assistere a riti di divinità che stanno in fondo al mare. Febbraio sta quasi passando e la ricetta della liatina dovevo metterla sul blog prima di Carnevale.
Per il resto, francese o non francese, viaggi, non viaggi o miraggi, ci saranno sempre simbolici maiali ammazzati, imbarazzi di ogni sorta da gestire, compleanni iniziati con un dolore da masticare a denti stretti e digerire in entusiasmi futuri e albe sempre pronte a consolare, il tempo – ogni volta – di sentirmi pronta anch’io… Respire! Un giorno, io e mamma metteremo di nuovo piede nella macelleria Di Francia che non è in Francia. E io tengo nella testa una liatina carica di sacrifici che non sono solo miei. Suona ancora come quelle litanie antiche: sono stata, sono e resterò sempre e soprattutto di un’isola.

Ingredienti
- 2 kg di parti definite “poco nobili” del maiale, composte da stinco, cotenna, orecchie, piedi, prosciutto, tracchie (puntine).
- 2 litri d’acqua
- Sale q.b.
- 2 bicchieri e mezzo di aceto
- Qualche foglia di alloro
- Peperoncino q.b. se gradito
Procedimento
Lavare per bene la carne e disporla in una pentola alta (na bella callara), ricoprire il tutto con acqua abbondante (circa 2 litri).

Accendere il fuoco a fiamma bassa e portare a ebollizione. Quando l’acqua bolle aggiungere il sale e lasciar bollire per una mezz’oretta. Verificare se la carne è cotta, togliere l’acqua superflua, aggiungere aceto, alloro e peperoncino e lasciar bollire ancora per 10 minuti.

Spegnere il fuoco, trasferire tutto nei recipienti di coccio da lasciare in un posto fresco in attesa che il liquido si solidifichi in gelatina (a liatina s’adda quagghià).
Le buone e le cattive del film*: è un espressione ispirata a “el malo o la mala de la pelicula”
Chimoffafà**: fusione foneticamente forse più efficace di “Chi mo fa fa”, chi me lo fa fare
Vesdine***: in procidano stretto vuol dire “insensibili” o dal sangue freddo.
Soba del cuy: si tratta di un rituale sciamanico ereditato dalle civiltà precolombiane, diffuso in Ecuador ma anche in Perù e Bolivia. Si tratta di una sorta di diagnosi di malesseri/malattie effettuate passando un porcellino d’India (il cuy) a qualche centimentro di distanza dal corpo della parsona che si sottopone al rito. In genere il cuy viene vivisezionato per osservare quali organi sono stati influenzati dalle patologie del o della paziente. Nel caso di M.P e dell’altra compagna di viaggio che decisero di sperimentare il rito, il cuy non venne ammazzato. Per saperne di più, consultare questo link, ma ce ne sono vari altri in spagnolo.